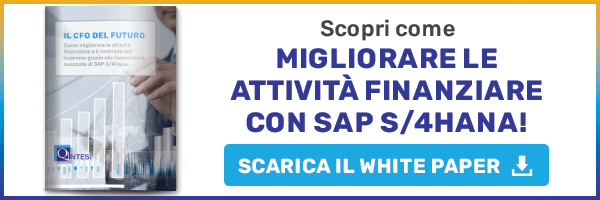Solvency II è già finita sotto la lente di ingrandimento a quattro anni dalla sua entrata in vigore, e ora sembra nuovamente prossima a una revisione. Voluta dalla Commissione europea, la revisione della Direttiva Solvency 2, che raccoglie le regole per il settore assicurativo finalizzate alla corretta calibrazione del capitale per una migliore gestione del rischio fa parte di un percorso ampio e articolato, destinato a concludersi nel 2021. Già nel 2020 Eiopa, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, organismo europeo che dal 2011 ha il compito di sorvegliare il mercato assicurativo e di coordinare le autorità nazionali competenti, aveva sollevato alcune eccezioni.
Solvency, la direttiva dell’Unione Europea per il settore assicurativo
Nell’ottobre 2020 Eiopa ha dato il via alla consultazione pubblica sul parere tecnico richiesto dalla Commissione europea ai fini della revisione della Direttiva Solvency 2. La procedura di consultazione è stata eseguita in una prospettiva di continuità, senza determinare cambiamenti sostanziali, ma piuttosto la messa a punto della disciplina normata da Solvency II, immaginando al più modifiche dettate dalle esperienze acquisite, senza stravolgimenti della filosofia di base della Direttiva.
Una nuova revisione, inoltre, è stata proposta e approvata a luglio 2023, dopo un parere positivo già esposto a giugno del 2022. L’idea alla base della nuova modifica è quella di adeguare la Direttiva Solvency 2 per semplificare le regole per la gestione dei capitali nelle assicurazioni, senza stravolgere i principi di base, universalmente riconosciuti come il “golden standard” mondiale, ma permettendo la liberazione di alcuni capitali attualmente non utilizzabili. Un cambiamento che, secondo gli esperti, ricalca la riforma del Regno Unito che, avendo ereditato la Direttiva Solvency 2 dall’Europa, ha autonomamente scelto di renderla più flessibile, pur conservandone la sostanza.
Ma a qualche anno dall’attuazione delle prescrizioni previste da Solvency II, cosa si può iniziare a dire?
Al di là dei pareri ufficiali emersi da Eiopa dall’Ue e dal Regno unito, è possibile formulare primo bilancio?
In linea di massima sì. E tutto sommato, pare che il sentiment generale si ponga a favore delle novità previste dalla Direttiva, con qualche necessità di ulteriore adeguamento.
Ma andiamo con ordine.
Solvency II: una nuova disciplina a garanzia dei consumatori
Solvency II è la Direttiva europea (2009/138/CE) che di fatto estende la normativa di Basilea II al settore assicurativo e prevede un approccio orientato al rischio (risk based) e “prospettico” (forward–looking), cioè incentrato anche sulla valutazione della capacità dell’impresa di gestire in modo puntuale i rischi, oltre che sulla verifica ex post del rispetto dei requisiti patrimoniali.
Senza entrare nei dettagli tecnici, per capire la logica di Solvency II è sufficiente sapere che un contratto di assicurazione si fonda su un principio: la restituzione in futuro, sotto forma di capitale o servizio, delle somme ricevute dal cliente – a titolo di premio assicurativo – con la sottoscrizione della polizza. Nell’attesa di soddisfare la promessa, le Compagnie di assicurazione di regola investono le risorse ricevute, in modo da accrescerne e non perderne il valore. Tali operazioni economiche, tuttavia, sono soggette a un certo livello di rischio. Non è detto infatti che tutti gli investimenti vadano a buon fine: esiste il rischio che nel corso degli anni l’assicuratore sia costretto a mettere mano al portafoglio per ripristinare i propri impegni a titolo di riservazione.
Per affrontare questa eventualità in modo previdente, l’Unione europea ha quindi imposto alle Compagnie di assicurazione di dotarsi di specifiche riserve per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati. Lo ha fatto appunto con Solvency II, Direttiva che introduce (tra le altre cose), il cosiddetto requisito patrimoniale di solvibilità (solvency capital requirement) a garanzia della disponibilità di fondi per l’impresa, non a copertura di specifici impegni, ma come ulteriore cuscinetto di sicurezza per soddisfare obbligazioni future anche in caso di scenari economici perturbati.
Requisiti quantitativi, qualitativi e di informativa
La forza di Solvency II risiede nella sua struttura a tre pilastri, che riflette un’impostazione organica della gestione del rischio. I requisiti quantitativi (Pillar I) definiscono la quantità di capitale che un’impresa deve detenere, mentre i requisiti qualitativi (Pillar II) riguardano la governance interna, i controlli e i processi decisionali. Infine, il terzo pilastro (Pillar III) introduce obblighi di trasparenza e comunicazione verso il mercato e le autorità di vigilanza. Questa architettura contribuisce a creare un sistema assicurativo più solido, coerente e orientato alla sostenibilità.
Solvency II come funziona
Il principio guida di Solvency II è il collegamento diretto tra capitale e rischio: maggiore è l’esposizione dell’impresa, maggiore deve essere la dotazione patrimoniale a garanzia della sua stabilità. La Direttiva ha così introdotto una nuova metrica di calcolo per il requisito di solvibilità, superando i vecchi standard di Solvency I, troppo rigidi e scollegati dalla realtà operativa delle imprese. L’obiettivo è avere un capitale di vigilanza aderente al profilo specifico di ogni compagnia.
Valutazione dei rischi
Con Solvency II, il rischio non è più solo una variabile da mitigare, ma un elemento centrale nella gestione dell’impresa. La valutazione dei rischi deve essere continua, prospettica e basata su scenari realistici. Le compagnie sono chiamate a svolgere regolarmente l’Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), un processo che consente di verificare se il capitale disponibile è sufficiente a coprire i rischi assunti. Questo approccio stimola un cambio di paradigma: non si tratta solo di rispettare obblighi regolatori, ma di integrare la gestione del rischio nella strategia aziendale.
Una Direttiva che concretizza un salto epocale
La Direttiva Solvency 2 è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 con l’intento di armonizzare al massimo la normativa europea e di collegare strettamente la definizione dei requisiti patrimoniali all’articolato e diversificato impianto dei rischi caratteristici di un’impresa assicurativa. Viene stabilito quindi un nuovo regime di adeguatezza patrimoniale e nuove regole di gestione e misurazione del rischio, con l’obiettivo di ottenere un capitale di vigilanza più aderente al profilo di rischio di ciascuna impresa. Per trent’anni prima di allora, il margine di solvibilità̀ è stato determinato seguendo, a macchia di leopardo, le regole di Solvency I: un meccanismo semplice, ma limitato. La determinazione del capitale di vigilanza, secondo la precedente modalità di calcolo, non prendendo in considerazione la misura del rischio, non consentiva una rappresentazione veritiera e coerente della reale necessità di Solvibilità, anche in modo pesantemente avverso nella rappresentazione dell’andamento di una compagnia assicurativa.
La stesura di Solvency II richiede dodici anni di lavoro e approda infine a una “nuova metrica” comune del rischio delle imprese assicurative, in sostituzione di 14 direttive e 28 regolamentazioni nazionali.
Ma qual è il grande salto che Solvency II concretizza?
Porre il rischio al centro dell’attività̀ d’impresa rappresenta un cambiamento epocale nella disciplina della vigilanza, ma non solo. Le imprese di assicurazione ora devono sottostare a una disciplina rigorosa: maggiori sono i rischi che intendono coprire con le loro polizze e che sono raffigurati nei loro piani strategici, maggiore è il capitale di cui devono disporre, in un costante equilibrio tra rischi e requisiti patrimoniali. Se, da un punto di vista teorico, l’impianto di Solvency II è dunque sacrosanto, la sua attuazione pratica non è del tutto immediata. Calcoli e adempimenti richiedono risorse importanti e il peso che ricade sulle spalle delle Compagnie assicuratrici con la nuova Direttiva non è indifferente.
L’unica eccezione che si poteva sollevare alla norma era la sua eccessiva generalità, che spesso rendeva la gestione dei capitali molto complessa. La nuova variazione effettuata nel 2023 va nella direzione di una supervisione basata sul rischio, in parte più flessibile.
Le conseguenze di Solvency II sull’industria assicurativa
Cosa possiamo dunque dire dell’impatto di Solvency II sull’industria assicurativa? Le conseguenze della Direttiva hanno avuto effetti in vari ambiti.
- Il grande valore aggiunto di Solvency II è stato quello di realizzare finalmente il mercato unico delle polizze assicurative, con una massima armonizzazione delle regole di solvibilità̀ e di vigilanza. Ma il processo di attuazione delle nuove norme non ha risparmiato le criticità.
Sul Volatility adjustment, la misura che permette alla Compagnia assicurativa di applicare una “correzione” additiva alla curva dei tassi risk-free utilizzata per calcolare le riserve tecniche, ha ad esempio scatenato vivaci dibattiti. L’Ania, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ha spiegato che la misura “non ha funzionato in maniera adeguata né tempestiva; la componente nazionale si è infatti attivata in modo irregolare e senza riflettere le effettive dinamiche di mercato”. Questo è accaduto, secondo l’associazione delle imprese assicurative, “sia perché le condizioni di attivazione della componente nazionale non hanno funzionato come avrebbero dovuto, sia perché i portafogli e gli indici utilizzati per il calcolo dell’aggiustamento non riflettono fedelmente il profilo di investimento della Compagnia e, quindi, i reali rischi cui è esposta”.
Una soluzione è stata trovata con una modifica tecnica al parametro, proposta nel corso della negoziazione relativa alla revisione delle competenze delle Autorità europee di vigilanza: novità che per l’Ania, “sebbene possa essere considerata valida e utile nel breve periodo, non affronta in modo strutturale i problemi di funzionamento alla base del meccanismo nato per contrastare la volatilità artificiale”. Anche di questo, dunque, si parlerà nel corso del processo di revisione di Solvency II citato sopra, che dovrebbe concludersi a fine 2020. - In attesa della revisione di Solvency II, l’EIOPA ha già espresso un suo generico parere: il quadro Solvency II funziona nel complesso bene. L’approccio della Direttiva è stato definito, nel testo con cui viene chiesto il parere tecnico di Eiopa, “di evoluzione” piuttosto che “di rivoluzione”. Le principali eccezioni – secondo quanto spiegato – derivano dall’esperienza di vigilanza, ad esempio in relazione alle attività transfrontaliere; o dal più ampio contesto economico, in particolare, in relazione al rischio di tasso di interesse.
- Nel quadro italiano, un primo bilancio di Solvency II è stato delineato da Ivass (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). In un convegno sul tema, l’Istituto ha toccato il tema delle criticità, puntando il dito contro “l’eccessiva complessità della misurazione del requisito di capitale, soprattutto per le piccole Compagnie” e auspicando l’attenuazione di “alcuni oneri normativi eccessivamente gravosi per gli investimenti in particolari classi di attivi”, come ad esempio per le obbligazioni prive di rating o per i titoli azionari non quotati. Criticità sono state rilevate da Ivass anche su un altro fronte: quello dell’operatività trans-frontaliera delle Compagnie europee, che viene trattata in modo diverso a seconda delle varie Autorità di vigilanza nazionali, “con livelli differenti di tutela degli assicurati”.
- Altro riscontro si è infine avuto nel giugno 2019, con la pubblicazione di alcune modifiche a Solvency II sull’Official Journal of the European Union (la gazzetta ufficiale UE): la Commissione Europea ha rivisto alcuni aspetti della norma rendendo, per esempio, l’investimento in azioni non quotate più interessante, abbassandone l’assorbimento patrimoniale dal 49% al 39%, allo scopo di permettere una maggior diversificazione degli investimenti. Nelle previsioni, la nuova Solvency renderà più appetibili le alternative non tradizionali di investimento come private debt o private equity, aprendo nuove strade di diversificazione del portafoglio.
Così come accaduto nel 2020, in cui il parere espresso da Eiopa non ha modificato i principi fondamentali della Direttiva Solvency 2, anche la nuova messa a punto del 2023 ne ha lasciati intatti i presupposti fondamentali: i legislatori europei, infatti, hanno sostenuto la necessità che gli assicuratori forniscano informazioni più complete sulla sostenibilità, sulla gestione del rischio e sulla rendicontazione rispetto a quanto proposto dagli Stati membri dell’UE, per fare in modo di poter fruire degli investimenti sbloccati dalla revisione 2023 della normativa. Questo, nonostante le pressioni ricevute da diversi gruppi di influenza per rendere le norme meno stringenti.